
Memorie di caccia
Voglio dedicare questo scritto agli amici di mio padre, persone che hanno condizionato la mia esistenza in modo radicale. Tutti i cacciatori che fanno parte di questo racconto sono vissuti realmente e sono stati parte della mia vita, come veri sono i fatti che narro nell'intento di mitigare la malinconia che mi assale ogni anno quando si avvicina l'apertura della stagione.
🔥 Entra nel nuovo Canale WhatsApp di IoCaccio.it 🔥
Fui dolcemente svegliato con un calcio da mio padre: “Ien quatr’ür, le üra de levas in pé!!!”
Queste furono le dolci parole che sentirono le mie orecchie quel fatidico mattino di ottobre dopo una serata passata con amici per locali bevendo e rimorchiando ragazze, o meglio cercando di rimorchiarle e rimediando solo dei bei sorrisi seguiti da un bel 2 di picche. La vita di noi Baldi giovani, allora, poco più che ventenni, era molto complicata è costellata di disavventure amorose di questo tipo, la guerra per quanto dura però andava combattuta, per cui forza e coraggio e pronti alla battaglia successiva.
Mio padre e mio zio, come del resto tutti gli appartenenti al nostro clan, erano Lepraioli prima di ogni altra cosa, per cui in piena stagione c’era poco da scherzare: tre volte a settimana la squadra era operativa e guai a non presentarsi senza adeguata giustificazione! Se ne fregavano bellamente delle mie kermesse amorose notturne, non c’erano santi in paradiso, soprattutto per me che ero e sono figlio d’arte.
“Mamma è il nome di Dio sulla bocca di ogni figlio”
Per fortuna mia madre, sentendomi rincasare piuttosto tardi (le mamme non dormono mai) si era già destata per mettere la caffettiera al fuoco, ricordo ancora il profumo di caffè misto a quello dei ceppi di rovere che bruciavano sul fuoco, riempiva la cucina e mi riempiva l’anima, è uno dei ricordi più belli che la caccia mi ha regalato e che conservo gelosamente nel cuore, il profumo della mia giovinezza, il profumo di casa. Oggi la caffettiera la prepara mia moglie, ma non è lo stesso profumo, o meglio il profumo non è cambiato, solo non è più il giovane cacciatore che lo sente ma l’uomo maturo, padre e marito, comunque, sempre cacciatore. In cuor mio spero sempre che l’essere uno mi aiuti a fare meglio l’altro e che i miei figli possano un giorno provare con candida tenerezza le stesse emozioni e sensazioni che ho provato io a suo tempo.
Bevuto il caffè, entrai in sala, aprii la fuciliera e scelsi tra le tante la mia doppietta Franchi 300 L che chiusi nel fodero. Infilai poi la mano nella scatola delle Remington Express piombo 4, prelevandone una sola fila: “5 cartucce dovrebbero bastarmi” pensai, convinto, in fondo, di non sparare neanche un colpo perché tanto la lepre sarebbe uscita a qualcun’altro.
Fuori dalla sala, in corridoio, trovai mia madre che mi aspettava, non aveva ancora proferito una sola parola da che si era svegliata, mi guardò seria afferrò dolcemente con entrambe le mani la mia zucca vuota e mi baciò teneramente la fronte… mio Dio quanto calore da quel semplice gesto!!!! Sono 2 anni che se n’è andata, e quando sento la sua mancanza, evoco questo ricordo che mi riempie il cuore e la sento sempre vicina a me. Ho realizzato col tempo che puoi avere 50 anni, essere un rude boscaiolo per professione, ma per tua madre sarai sempre “il bambino”. Mi piace, in questi frangenti, citare il fumettista James O’Barr nel suo capolavoro de Il Corvo: “Mamma è il nome di Dio sulla bocca di ogni figlio”.
Quel giorno si faceva sul serio
Raggiunsi mio padre ai serragli dei cani, c’erano circa 20 segugi italiani a pelo raso nei box in attesa di essere scelti per la battuta di quel giorno, vidi però mio zio uscire con la muta di punta, composta da Falco, Cita, Dominique, Pelé e la Ula la capo muta, per cui capii che quel giorno zio Mario faceva sul serio.
Scelta mirata e non fatta a caso. Quando arrivai a casa la mattina del giorno prima della battuta in questione, mio padre dopo avermi salutato, mi comunicò che il mattino successivo sarei stato “dispiegato” sul campo, in modo lapidario e senza entrare in particolari, cosa abbastanza insolita. Mia madre mi raccontò poco dopo, ridendoci su, che c’era una lepre particolarmente scaltra che li aveva beffati già un paio di volte in malo modo, e quest’onta andava lavata col sangue. Fu così che la cacciata si trasformò in una vera questione d’onore per la squadra.
La squadra
Erano ormai le cinque del mattino quando giungemmo al “Corona”, osteria in cui si riuniva di solito tutta la squadra. Seduto sulla sedia fuori dalla porta che fumava c’era “il Franco Mandrini”, classe 1942, un caro, carissimo amico di famiglia che oggi non c’è più e di cui conservo a ricordo il fucile, un Benelli 121 con canne Saint Etienne del 1968, che mi regalò appena prima di morire. Era talmente attaccato a mio padre e a mio zio che si metteva fuori ad aspettarli nonostante il freddo e l’umidità tipiche della provincia pavese nel mese di Ottobre, erano i primi anni 90 del secolo scorso ed il clima ancora non dava i numeri come invece pare fare oggi. Fino ad allora avevo accompagnato la squadra solo in qualche occasione, dedicandomi pienamente al cane da ferma. Vedendomi scendere dalla macchina col fucile in spalle si illuminò, giunti alla porta del bar ci salutò con calore ed entrando mi diede una pacca sulla spalla e ridendo disse: “l’era Üra che ta sa decideva a vegnì a legür” come per dire “era ora che ti decidevi a cacciare la lepre con noi”. Sorridendo lo seguii al bancone.
Gli sfottò nei miei confronti erano all’ordine del giorno tra i componenti della squadra, dopo tutto ogni amico che ne faceva parte mi aveva visto nascere e poi crescere, erano tutti in fondo di famiglia, frequentavano abitualmente casa di mio padre e non nascosero mai la soddisfazione che provarono quando presi la licenza dato che, figlie a parte, non avevano eredi da avviare all’attività. Personalmente non badavo troppo a quello che mi dicevano e se lo facevo, era per riderci sopra, ognuno di loro nella mia vita è stato un punto di riferimento, come potevano non esserlo? Erano persone “antiche”, genuine, toste, gente che lavorava tutta la settimana duramente senza risparmiarsi per sé e per la propria famiglia, chi nei campi, chi era artigiano, chi muratore, chi meccanico, chi accademico (c’era anche un Doc) tutte persone da cui si poteva imparare tranquillamente la vita in tutte le sue sfumature, dei veri esempi da seguire, fatti di una fibra morale che ahimè oggi stento a trovare tra la gente.
Chiesi un caffè al Mario, l’oste detto bonariamente “Orso Bruno” che me lo servì in una tazza bollente. Entrarono intanto dalla porta “il Giorgio” classe 1935 e “il Pepino Scheia” classe 1932 (da noi Scheia è il termine dialettale per definire il ciuffo di capelli frontale messi di lato oppure la scheggia di legno che buca le dita) gli altri due membri della formazione di quel giorno. L’ora era buona e c’era tempo per fare due risate in compagnia. Qualcuno arrivò a chiedermi persino se avessi in tasca le cartucce, risposi: “Cinque di quelle buone, Remington del 4”. L’orso Bruno ridendo mi rispose: “Ricordat… Basta tirà driss cujon che tut i cartüc ien bon!!!”. Che dire? Sillogismo aristotelico di prim’ordine!
Partimmo tutti quanti insieme, noi tre più il Franco sulla Fiat 127 con i cani che latravano per l’impazienza svegliando mezzo paese e gli altri due che ci seguirono con una seconda macchina.
I preparativi
Giungemmo sul terreno di caccia appena passate le 5,30. Era un mattino di quelli velati, con cielo grigio e nebbiolina, tipico del mese di Ottobre. Ci preparammo con calma, chi infilò i gambali della cerata, chi sfilò il fucile dal fodero e chi buttò nel carniere una fila di “cacciatorini stagionati” e una fiasca di vino rosso, che non si sa mai. Io aprii la mia doppietta, dopo averla sfilata dal fodero, e la poggiai sulla spalla, a quel tempo non apprezzavo troppo le cinghie, preferivo avere il fucile tra le mani aperto perché mi faceva sentire più sicuro nell’evitare incidenti, lo chiudevo solo per sparare quando il cane cadeva in ferma o se scoppiava la canizza dietro la lepre.
Nei due giorni precedenti la pioggia autunnale era caduta incessante, per cui in quel mattino di breve sosta si rese necessario verificare il territorio. A mio zio, capo squadra, toccò il compito di tracciare passate fresche con la capo muta al guinzaglio, mentre noi restammo tutti in attesa dell’orario previsto dal tesserino venatorio per poter cominciare la battuta.
Tornó dopo 40 minuti.
Volto grave, lineamenti tesi, proferì la sua sentenza: “la ghe, ma ghe giù anca un pari da legürat e un masch bel gros!” Questo aveva capito dalle fatte ritrovate sul terreno delle pasture notturne. Frase limpida che cela un “non detto ma sotto inteso”: era chiaro per tutti che le prede da considerare durante la battuta erano la femmina scaltra per cui si era li, e il grosso maschio che girava in zona. I due giovani andavano risparmiati, era il loro modo di vivere la caccia, che non si limitava nel solo “qui adesso” ma vedeva lontano, alla stagione successiva.
L’ambiente circostante era caratterizzato da numerosi granturchi ancora in piedi, intervallati da prati di erba verde da fieno. Alcuni boschetti di pioppo sfrangiavamo il cielo grigio del mattino, se il sole si fosse presentato avrebbero fatto ombra sulle rive dei fossi irrigui che li dividevano da alcune stoppie di grano mietuto a Giugno. Alcuni incolti infine, chiudevano la zona di caccia prima che si giungesse sulle rive del Naviglio di Bereguardo. In fin dei conti un ottimo terreno.
Mio padre dispose le poste, mi tocco un “incaster” cioè una chiusina fatta da assi di legno appoggiate a una lastra di sasso che univa le rive del fossato formando un ponticello di 30 cm di larghezza che poteva fungere da passatoia per la lepre in fuga.
Alla mia destra il Franco, a Sinistra Il Pepino, entrambi distanti da me due tiri l’uno, poi sul lato più corto Il Giorgio con Papà, e zio Mario, che come sempre gestiva i cani da vicino, era lui che li accudiva tutti i giorni e li addestrava alla caccia e a lui solo davano retta.
Una normale giornata di caccia…
Giunse l’ora, mio padre segnalò l’inizio della battuta a gesti al Pepino e lui passò parola a me ed io a mia volta al Franco. Nel primo granturco non trovammo nulla, sentimmo solo uno scagno poco convinto in mezzo al campo ma non scoppiò nessuna canizza.
Nel secondo granturco, invece, sentimmo due e tre scagni di Falco, lo scovatore, e poi a seguire Ula la capo muta, che partendo si portò tutti gli altri dietro e fu così che partì la prima canizza della giornata.
“Siamo in ballo mi gridò il Franco”. Chiusi il fucile in attesa… or ora la muta si dirigeva verso la mia posta, or ora cambiava direzione. Quando la sentivo arrivare iniziavo ad agitarmi, soffrivo di ansia da prestazione: “Se la sbaglio?” Era il mio pensiero, non ero un granché a sparare in terra, di conseguenza sentivo il peso di questa responsabilità, non volevo deludere la squadra né tanto meno Zio e Papà. Mi sentivo meglio solo quando la canizza si allontanava, ed ero sicuro che se usciva a qualcun’altro si sarebbe fatto carniere.
Quella volta, invece, era destino che vincessi sulle mie ansie. Sentii la muta avvicinarsi in modo repentino, frenetico e solo allora mi resi conto di quanta ferocia racchiudevano gli abbai dei segugi, una ferocia atavica, primordiale, selvaggia, una ferocia figlia di migliaia di anni di evoluzione per cui la preda è fonte di cibo per sé e per i propri cuccioli, è la vita o la morte per stenti, è l’istinto di sopravvivenza che vince su ogni altra cosa. Stranamente mi sentii più sicuro di me stesso, forse perché finalmente iniziavo a comprendere le cose per come erano in realtà. Iniziavo a vedere ciò che stavo facendo sotto un altro aspetto. La muta si avvicinava sempre più e sempre più la consapevolezza sopraggiunta mi faceva sentire pronto ad assolvere al mio compito. Mancavano pochi metri che vedessi spuntare la muta da dentro il granturco, ed ecco che con un lungo balzo vidi schizzare letteralmente fuori dal granturco un animale che non mi aspettavo di vedere, senza che potessi pensarci nemmeno per un secondo imbracciai e stoccai la mia fucilata, prima un colpo poi il secondo vidi l’animale fermarsi e mordersi un fianco, cercando di togliere un qualcosa che non vedeva e che gli impediva di andarsene via. Era successo tutto talmente in fretta da intontirmi.
Restai attonito, quasi in sospeso senza rendermene conto. A ridestarmi fu il sopraggiungere dei cani, ed iniziai a fare caso anche alle grida del Franco e del Peppino che mi correvano incontro, urlandomi di togliere la “Volpe” dai denti dei cani.
Mi avvicinai e cercai di prenderla in modo che i segugi non la facessero a pezzi, ma la doppietta senza cinghia mi impacciava una mano mentre l’altra era impegnata a sottrarre la carcassa alle fauci dei cani che selvaggiamente non rinunciavano al loro premio. Per fortuna sopraggiunsero in breve gli amici per aiutarmi, sorridendo mi diedero pacche sulle spalle mentre cercavano di tenere a bada i segugi e si congratularono con me per come avevo risolto quella situazione.
Arrivò zio Mario che iniziò a mettere i guinzagli ai cani. Quando ebbe sotto controllo la muta si avvicinò a Franco e chiese: “Chi l’è che l’ha spará?” Franco sorridendo rispose: “To neud”.
Si girò verso di me, mi guardò con approvazione, mi strinse la mano e mi disse: “Brau!! Bel Tir!!!”.
Mio padre e il Giorgio che nel frattempo arrivavano camminando, vedendo il quadretto capirono chi aveva fatto carniere. Mi vennero in contro e si congratularono con me, mio padre orgoglioso mi abbracciò, il Giorgio invece cavò dalla “saccoccia” una fiasca di ferro con dentro della grappa e mi disse: “in queste occasioni serve brindare”. A cosa però non capii immediatamente, avevo ucciso una volpe non una lepre. Bevvero tutti uno ad uno, poi toccò a me. Nessuno disse nulla, nessuno spiegò nulla.
La volpe è un predatore, si ciba di uccelli e roditori, oltre a tutto il resto, è una catastrofe soprattutto per fagiani e starne che i cacciatori lasciano a scopo di ripopolamento, mena stragi tra le poche nidiate che nascono in natura, porta con sé la rogna e non disdegna di attaccare i pollai dei contadini se non trova di meglio in giro. In natura ha la sua utilità, ma se il numero di esemplari supera la tolleranza massima per un dato territorio allora si deve intervenire. È un avversario astuto, veloce e imprevedibile, combatterà fino all’ultimo minuto e non si darà mai per sconfitta. La si caccia allo stesso modo della lepre, solo che durante la caccia siamo soliti ricoprirla d’insulti, di bestialità e quando la si uccide da una certa strana ed inspiegabile soddisfazione. Questa può sembrare una brutalità ma se si legge tra le righe ci si rende conto che, seppur grezzo, è il nostro modo di rispettare il nemico, un nemico valoroso alla quale nel profondo di noi stessi porgiamo omaggio.
La vecchiarda e il leprone
La caccia riprese come se nulla fosse accaduto, o meglio come se quello che era accaduto fosse un nulla, era dopotutto una normale giornata di caccia, per tutti forse ma non per me. Era la mia prima volpe, ed era la prima volta che uccidevo un animale che non avrei potuto mangiare. Stentavo a capacitarmene.
Mentre rimuginavo su quello che mi era appena accaduto una nuova canizza mi riportò al presente. Durò forse 10 minuti poi si interruppe senza sparo. Vidi il Franco ed il Peppino portarsi velocemente nella direzione di un incolto incastrato tra una soia ed una stoppia di granturco poco estesa. Mi fecero segno di posizionarmi sullo stradello adiacente. Sopraggiunse mio Zio, chiamò a se i cani, quando li ebbe vicini incitò la Ula ad entrare nella stoppia con tutti gli altri cani. Pochi attimi bastarono a Falco per scovarla e a Cita, grande inseguitrice, per “buttarla in piedi”. Percorse tutta la stoppia di granturco per giungermi davanti alle canne del fucile. Sparai il primo colpo, sparai il secondo e la vidi andar via forte come il vento portandosi dietro tutti i cani, bestemmiai a più non posso per la rabbia. Per fortuna si presentò a mio padre e mio padre ci mise una pezza sopra. Un solo tiro e la lepre giaceva vinta ai bordi dell’incolto.
Era lei, la vecchiarda che si era presa beffa della squadra. Ora era sorretta da mio padre, con i segugi che ne bramavano le spoglie. Ci riunimmo per contemplarla e di nuovo saltò fuori la fiaschetta della grappa. Tutti bevemmo alla salute della lepre, che si era battuta con onore, e bevemmo alla gloria dei segugi, i veri proprietari della preda, coloro senza i quali non sarebbe possibile nulla di tutto questo.
Mi trovai con una sola cartuccia in tasca, dovetti chiederne una a mio padre. Il gesto non passò inosservato.
Dopo un’ora circa in cui non trovammo segno di presenze leprine, comunque già soddisfatti del carniere, ci dirigemmo alle macchine per rincasare. Fu in quel momento che Dominique si infilò in un granturco ed iniziò a scagnare all’impazzata. Il Franco che camminava al mio fianco disse guardando l’orologio: “se la ghe fra cinq minut la salta föra o la rampega sü per la pianta”. Corsero per prender posizione ma non servì. Saltò fuori un grosso leprone a circa venti passi da me, gli scaricai la prima fucilata dietro un metro ma con la seconda ebbi fortuna. Il maschio le cui fatte furono trovate da mio zio la mattina presto durante la tracciatura, giaceva sullo stradello immobile, feci appena in tempo a sollevarlo dal suolo che arrivarono i cani. Tornammo in paese soddisfatti.
Quella sera al “Corona”
La sera raggiunsi mio padre al “Corona”. Quando entrai lo vidi seduto fra gli altri cacciatori del paese. Qualcuno mi salutò, qualcun’altro si complimentò per il carniere che contribuii a realizzare. C’era una sedia libera al suo tavolo e mi adagiai su quella. Iniziai a chiacchierare con i presenti. L’Orso Bruno passando con un paio di grappe in mano colse occasione di ricordarmi la sua massima: “Basta tirà driss cüjon che tutt i cartüc ien bon”, e ci fu chi gli fece eco tra le risate … però mi accorsi per istinto che qualcosa era cambiato rispetto al solito, gli sguardi degli altri soprattutto, ed il modo in cui, ad un certo punto, si rivolsero a me. Mi sentii rispettato e considerato, come se fossi stato uno di loro, anzi mi trattarono proprio come uno di loro. Cosa era cambiato in fine? Nulla in particolare, solo una giovinezza che volata via lasciò spazio alla maturità, non solo, in quel momento divenni parte di una grande famiglia, non più considerato ragazzo ma a tutti gli effetti un adulto loro pari e potevo dunque considerarmi un cacciatore a pieno titolo.
Questo però non bastò a risparmiarmi gli sfottò che i nostri mi riservarono riguardo la padella del giorno e del fatto che dovetti chiedere una cartuccia a mio padre, “ti sia da monito per il futuro, non si esce mai di casa con le cartucce contate, non sai mai dove vai a parare” questa fu la morale più gettonata … e continuarono per tutta la sera, senza smettere. Dal mio canto ero troppo soddisfatto per badarci, anzi non mi importò affatto che continuassero, perché sapevo che dopotutto era solo il loro modo per farmi sentire a casa.



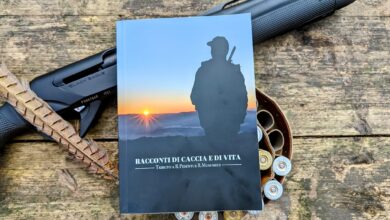


Mi ci rivedo giovani stasse esperienza indimenticabile che resterà per sempre nel mio cuore. Ecco questa è la caccia leale e meravigliosa esperienza di vita ed amicizia
Buon giorno Marco, sono felice di rievocare momenti felici della tua gioventù, ti ritengo quindi un fortunato come il sottoscritto perché hai vissuto veramente momenti indimenticabili, momenti che nessuno mai potrà portarti via, il mio augurio è che tu possa continuare a vite la tua passione intensamente come allora.
Stefano Casella